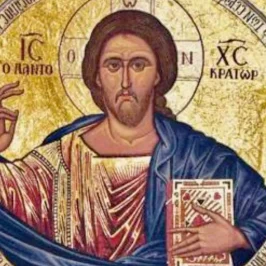“Convinti ma soprattutto uniti”
Queste parole con cui Mons. Giuseppe Agostino di v.m. invitava la Chiesa di Cosenza – Bisignano a recuperare il primato della liturgicità e dell’interiorità nella celebrazione delle feste popolari mi sembrano possano aiutare ad ribadire lo spirito giusto con cui bisogna vivere questo momento di crescita per l’intera Chiesa locale, Non si tratta infatti di voler fare da padroni sulla fede della nostra gente ne tanto meno di mortificare l’espressione popolare del suo sentire religioso ma piuttosto di continuare quel cammino di rinnovamento della Chiesa avviato con la celebrazione del Concilio Vaticano II e mai concluso che vede la comunità cristiana «popolo dell’alleanza, convocato per la lode, nell’ascolto della tua parola e nell’esperienza gioiosa dei prodigi della storia della salvezza» (cfr prefazio V di Quaresima) porsi in uno stato di continua conversione perché in ogni suo gesto e parola possa risplendere la bellezza che il suo Sposo e Signore continuamente le comunica. Dunque nessun taglio con una storia bella anche se necessariamente rugosa ma un ritrovare motivazioni, criteri e orientamenti in grado di immettere nuova linfa in un albero dalle radici profonde ma che deve e può dare ancora i suoi frutti.
Perché il primato della Liturgia?
Quando come Diocesi ci siamo trovati a mettere in pratica le sagge indicazioni di Mons. Agostino non mancarono, come si può immaginare, le più diverse e a volte anche forti reazioni. Tra le molte era interessante notare il fervore con cui molte Pro Loco si ergevano a paladine delle tradizioni ereditate dai padri contro la volontà di un Vescovo e di una curia insensibile che voleva togliere le feste. Per cui al grido che “il Santo è nostro” si faceva a gara a invitare storici e soprattutto antropologi che con toni scientifici dovevano dimostrare, non senza una certa venatura di ideologia, che la riforma della gerarchia ecclesiastica non era altro se non l’abuso di potere dei forti contro il linguaggio dei semplici. Ho voluto narrare questo aspetto perche si può correre il rischio di entrare in una pericolosa contrapposizione nell’ottica quasi di una lotte di classe tra la liturgia e la pietà popolare come se l’oggettivo primato della prima sia un semplice strumento di affermazione di un potere gestionale sulle masse. Tra i doni che il Concilio Vaticano II ha fatto alla Chiesa vi è senza dubbio tra i primi, se non altro per un mero aspetto cronologico, quello di aver ribadito la centralità di Cristo nell’azione liturgica della Chiesa. Cosi si è compreso, almeno a livello teorico, che non è la Chiesa a dare un importanza al suo celebrare, al pari di un dovere religioso necessario a placare una dio alquanto incerto nelle sue intenzioni e nel suo operare, ma la presenza attiva e salvifica del Risorto a fondare il motivo stesso del suo celebrare.
«Effettivamente per il compimento di quest’opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale l’invoca come suo Signore e per mezzo di lui rende il culto all’eterno Padre. Giustamente perciò la liturgia è considerata come l’esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa, la santificazione dell’uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi; in essa il culto pubblico integrale è esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia l’efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado.» (SC7). Dunque tutti noi siamo invitati, come egregiamente richiamato da Papa Francesco nella lettera apostolica Desiderio desideravi, ad entrare sempre nuovamente in quella singolare unicità del culto cristiano che lo rende necessario e insostituibile perché tutto racchiuso in un dono che non dovrebbe mai smettere di suscitare stupore e commozione: non è l’uomo a morire per Dio ma Dio a consegnarsi gratuitamente per la salvezza dell’umanità. Nell’acquisizione di questa ottica ci è maestra la liturgia stessa che nella preghiera eucaristica IV ci fa pregare dicendo: «in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il suo Corpo e il suo Sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero… Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa», sottolineando che la Chiesa nel momento più alto del suo convenire in uno non può fare altro che offrire quanto ha ricevuto dalle mani del Padre. Se dunque la liturgia non è altro che l’agire di Cristo, nessun’altra azione umana anche la più nobile e sincera potrà mai uguagliarla nell’efficacia e nel valore. Questo netto primato di Dio che come tale è il soggetto e non il destinatario o l’oggetto del culto cristiano non mortifica l’uomo nella sua naturale vocazione alla trascendenza, al contrario la integra e la eleva, salvaguardando l’uomo stesso dal pericolo di chiamare “dio nostro” l’opera delle proprie mani (Cfr Os 14,4). Come dunque insegna il Concilio e sulla sua scia il magistero fino ai nostri giorni, la Liturgia, salvaguardando cosi anche se stessa dal pericolo del panliturgismo di cui metteva in guardia il grande Romano Guardini, non esclude o disprezza la pietà popolare ma la accoglie integrandola e orientandola come espressione di un bisogno di comunione e di salvezza, Giacché infatti la pietà popolare nasce come linguaggio spontaneo e immediato della fede, legato alla storia e alla cultura di una comunità, corre il rischio di diventare autocelebrazione, produzione di emozioni religiose rasentando in alcuni casi il superamento del razionale, o rievocazione di un passato mitico che mette al sicuro dalle fatiche del presente. In altre parole il primato della Liturgia è un bene per la vitalità stessa della pietà popolare perché le dona un battito d’ala riaprendola a quel respiro che è ricerca, desiderio, bisogno di ritrovare il gratuito e soprattutto apertura ad una novità che non può essere prodotta dalle mani dell’uomo. Se però la Liturgia orienta la pietà popolare al primato di Dio che in qualche festa può apparire il grande sconosciuto o il silenzioso assente, anche la pietà popolare aiuta la Liturgia a custodire e rinnovare quella dimensione propriamente umana che, a partire dal grande mistero dell’Incarnazione del Verbo, ne costituisce l’indispensabile via della salvezza, In questo senso ci sono di grande aiuto e stimolo le parole del proemio di Sacrosanctum Concilium che in una prima e pallida ecclesiologia, appena sussurrata, al numero 2 ricorda che la Chiesa « ha infatti la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, fervente nell’azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina; tutto questo in modo tale, però, che ciò che in essa è umano sia ordinato e subordinato al divino, il visibile all’invisibile, l’azione alla contemplazione, la realtà presente alla città futura, verso la quale siamo incamminati » (SC2).
L’anno liturgico e l’anno devozionale
La liturgia cristiana infatti non è altro se non la continua celebrazione di quel “propter nos – per noi uomini e per la nostra salvezza” con cui il simbolo della fede ci ricorda la logica dell’agire di Dio nella storia e la conseguente trasformazione del tempo come momento propizio della nostra salvezza. A partire da ciò che ha condotto il tempo alla sua pienezza (Cfr Gal 5) si comprende il senso vero e necessario dell’Anno Liturgico che lontano dall’essere considerato un semplice susseguirsi di feste o di sacri ricordi, come già definito da Pio XII nella prima enciclica della storia della Chiesa sulla liturgia, la Mediator Dei del 1947, è « Cristo stesso, che vive sempre nella sua Chiesa e che prosegue il cammino di immensa misericordia da Lui iniziato con pietoso consiglio in questa vita mortale, quando passò beneficando allo scopo di mettere le anime umane al contatto dei suoi misteri, e farle vivere per essi; misteri che sono perennemente presenti ed operanti… ». L’anno liturgico dunque non è il corrispettivo del calendario scolastico, accademico, giudiziario o l’alter ego dell’anno civile ma la concretizzazione di quella parola che il Maestro rivolse un giorno a dei pescatori lungo le rive del mare di Galilea con la quale li invitava a seguirlo. Da allora ogni battezzato sentendo come rivolta a lui questa divina chiamata muove i suoi passi sulle orme di Cristo per imparare lui e vivere di lui “fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo” (Ef 4,13), una misura mai definitivamente acquisita che perciò spinge il credente a rinnovare la propria esperienza di Cristo in un continuo stato di conversione non dettato da leggi o divieti ma dall’incontro con la luce sfolgorante del Mistero Pasquale. Il cammino della comunità credente lungo l’itinerario salvifico dell’Anno Liturgico nasce dall’esperienza trasformante della Pasqua comunicata a noi nel Battesimo e sempre rinnovata dalla celebrazione dei divini misteri che per la sua intrinseca dinamicità fa uscire l’uomo dalle secche del peccato e della morte e, mettendolo a confronto con Cristo l’uomo nuovo, lo avvia ad un cammino di liberazione e di umanizzazione. Non si può essere uomini e donne nuove senza Cristo ecco perché abbiamo sempre bisogno di imparare Cristo non attraverso operazioni speculative o intimistiche ma mediante processi immersivi. Il battesimo immergendoci nella Pasqua dona alla fede cristiana questo statuto proprio e vitale che ci permette di vedere il dono del credere come un vivere in Lui, un rimanere costante come garanzia certa di portare quei frutti desiderati. Non ci meraviglia quindi se all’indomani della fine delle persecuzioni, nel IV secolo, quando la Chiesa poteva godere della tanto sospirata libertà di culto mettendosi alle spalle, almeno illudendosi per un poco, la tragica epoca delle persecuzioni di stato si avvertì subito il bisogno di fornire a coloro che avevano scelto di seguire Cristo uno strumento in grado di tenere viva la fiamma della fede e di custodire, secondo il detto dell’Apostolo, lo specifico della loro presenza nel mondo: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.» (Rm 12, 1-2). La celebrazione dei divini misteri è pensata dunque come sequela Christi e stimolo alla sua imitazione: camminare con Cristo o meglio lasciarsi da lui guidare per essere sale del mondo e luce della terra. Il bisogno e la necessità di tenere fisso lo sguardo sul Cristo “colui che dà origine alla fede e la porta a compimento” (Eb 12,2) ha guidato la progressiva strutturazione dell’Anno Liturgico che partendo dal suo cuore vivo e pulsate cioè la Pasqua ha cominciato a fissare l’attenzione orante sui vari aspetti della vita del Salvatore che proprio alla luce della Pasqua hanno rivelato il loro carattere di rivelazione e perciò di misteri della fede. Questa struttura della fede non ha seguito infatti nel suo sviluppo un criterio lineare o storiografico ma teologico per cui le varie feste del Salvatore sono nate e si sono disposte nell’arco temporale di un anno sia come professione di fede, basti pensare in questo caso allo sviluppo del ciclo natalizio intimamente legato alle varie dispute teologiche sulle due nature di Cristo, sia come volontà della coscienza cristiana di dare un’immagine di Cristo più umana e immersa nella storia.
«Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti ». (Eb 1,12). All’interno di questo processo di divinizzazione dell’umano, l’esortazione dell’autore della lettera agli Ebrei ci aiuta a cogliere il significato più bello e vero della memoria dei Santi con cui nelle varie epoche la comunità cristiana non ha mai esaltato degli eroi ma ha voluto celebrare la salvezza donata da Dio all’umanità in Cristo risorto dai morti. Infatti come ricorda il bellissimo testo dell’ Annunzio del giorno di Pasqua proclamato nella liturgia della solennità dell’Epifania, « anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella commemorazione di tutti i fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore ». Eco di questo antico testo del Rito Romano recuperato dalla Riforma Liturgica del Concilio è il n 104 della costituzione sulla Sacra Liturgia in cui si afferma che «la Chiesa ha inserito nel corso dell’anno anche la memoria dei martiri e degli altri santi che, giunti alla perfezione con l’aiuto della multiforme grazia di Dio e già in possesso della salvezza eterna, in cielo cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi. Nel giorno natalizio dei santi infatti la Chiesa proclama il mistero pasquale realizzato in essi, che hanno sofferto con Cristo e con lui sono glorificati; propone ai fedeli i loro esempi che attraggono tutti al Padre per mezzo di Cristo; e implora per i loro meriti i benefici di Dio». (SC 104). Il rapporto con la Pasqua è dunque il motivo fondante per il quale all’interno del percorso di “imitazione del Signore” che è l’Anno Liturgico non poteva non trovare doverosamente posto la memoria di Colei “che tutte le generazioni chiameranno beata” e di quella immensa schiera di testimoni della fede “nella cui vita il Signore offre un esempio, nella comunione con loro un vincolo di amore fraterno, nella loro intercessione aiuto e sostegno per affrontare il buon combattimento della fede e condividere la stessa corona di gloria“. (Prefazio dei Santi). Dunque la memoria dei Santi e la loro relativa celebrazione inizialmente riservata ai martiri e poi, dopo la fine delle persecuzioni, estesa a tutti i confessori della fede, cioè a tutti coloro che hanno testimoniato eroicamente la fede, vengono inseriti nel corso dell’anno in un’ottica di esempio per la comunità e quindi di stimolo al cammino della sequela di Cristo, tanto che, semplificando, si può affermare che nel primo millennio l’esemplarità ha la priorità sull’intercessione la quale, essendo parte integrante del mistero della Comunione dei Santi, conserva tutta la sua valenza e il suo fondamento teologico. Nel secondo millennio sopratutto a partire dal XII secolo si assiste alla nascita e al fiorire di un movimento spirituale che tanto influenzerà la vita di fede del cristianesimo di occidente e di cui noi ancora oggi sentiamo gli effetti: la devotio moderna. Con tale definizione si va a indicare un nuovo atteggiamento con cui ci si approccia alla liturgia e alla venerazione dei santi. Essendo venute meno le categorie antiche di partecipazione alla liturgia vista non più come luogo di esperienza del mistero di Dio ma come atto di culto svolto da alcuni “addetti ai lavori”, i chierici che occupano un posto sempre più elevato e separato rispetto al resto dell’assemblea, a favore del popolo, quest’ultimo sente la necessità e il bisogno di avere una nuova fonte alla quale poter attingere per soddisfare il proprio bisogno di Dio. Tale fonte viene trovata nella meditazione dei misteri della salvezza attraverso l’immedesimazione nei sentimenti del Signore, della Vergine e dei Santi per cui la messa diventa il luogo nel quale rivivere la meditazione della passione del Signore e nascono atti di pietà (novene, tridui, suppliche) nei quali, appellandosi all’intercessione dei santi, dei quali ci si fa più devoti che imitatori. si chiede di condividerne i sentimenti per essere interiormente trasformati. Questo atteggiamento nato per colmare in parte il vuoto lasciato dalla non piena e comprensibile partecipazione alla Liturgia genera uno spostamento dell’attenzione celebrativa dal Temporale, cioè i tempi forti dell’anno in cui si vivono e si ricordano (cfr Annunzio del giorno di Pasqua) i misteri della nostra salvezza al Santorale che prende cosi il sopravvento fino a far retrocedere e far cadere in sordina l’anno liturgico soppiantato dall’anno delle devozioni scandito da mese, quindicine, novene e via di seguito. Questa visione devozionale del celebrare cristiano se da un parte manifesta la necessita che la comunità avverte, pur nel variare delle epoche e dei linguaggi, di strumenti in grado di sostenere il cammino dei discepoli del Signore, dall’altro evidenzia un certo spostamento, non voluto almeno nelle intenzioni iniziali, dal centrale al periferico, dal contatto vivo con il Cristo crocifisso e risorto ad un ricordo pieno di commiserazione e di pietà, cosi come dal partecipare all’eucaristia al solo contemplarla all’elevazione dei santi doni. In questo modo oltre a isolare il culto dei santi dal loro contesto originale, si è favorita la nascita di una spiritualità privata più che comunitaria nella quale la comunità cristiana diventa il semplice luogo della santificazione del proprio io e non più il grembo dell’esperienza del Corpo mistico di Cristo. Non meraviglia se la riforma protestante andando ad aprire una ferita all’interno della compagine ecclesiale apparirà come la ferrea ricusatrice del culto dei santi di cui in realtà si mette in ombre il solo aspetto di intercessione che in alcuni casi sembrava oscurare la mediazione di Cristo e la sua opera redentrice per conservarne la positiva esemplarità.
La domenica e la sua celebrazione antidoto alla secolarizzazione
Come ricorda il numero 1 di Sacrosanctum Concilium tra le motivazioni fondanti della volontà di convocare e celebrare la grande assise conciliare vi era quella primaria di rinnovare la vita cristiana, criterio guida dell’intera riforma liturgica desiderosa non tanto di tagliare con un passato dando origine ad un nuova Chiesa quanto piuttosto di riportare i cristiani a quella prima e indispensabile fonte dalla quale attingere il genuino spirito cristiano (cfr SC 14) che è la Liturgia, perché il contatto vivo con la storia della salvezza li introducesse sempre di più nella pressante carità di Cristo e li infiammasse con essa (cfr SC 10). In questa riscoperta del tesoro salvifico e pedagogico della Liturgia si incastona una nuova presa di coscienza dell’importanza dell’Anno Liturgico ridonato alla comunità come normale cammino di fede di cui la domenica, giorno del Signore Risorto, è il pilastro portante. La volontà di ripristinare il vero senso festivo di questo giorno archetipo di noi cristiani era già stata portata avanti all’inizio del novecento da alcuni interventi di riforma del Papa San Pio X che aveva eliminato dal Calendario Romano l’uso di celebrare in domenica le feste dei Santi, abolendo tale prassi anche dal Breviario Romano nel quale la domenica tornava ad avere la precedenza su ogni altra festa. La lungimiranza di Papa Sarto che nel Motu Proprio “Tra le sollecitudini” aveva auspicato una partecipazione attiva di fedeli alla celebrazione dei divini misteri diventerà il filo conduttore della ricerca e dell’approfondimento portato avanti per più di mezzo secolo dal Movimento Liturgico e poi sfociato, come a sua felice conclusone, nel documento conciliare sulla Liturgia. Esso infatti afferma che «ogni settimana, nel giorno a cui ha dato il nome di domenica, fa memoria della risurrezione del Signore, che essa celebra anche una volta all’anno, unitamente alla sua beata passione, con la grande solennità di Pasqua » (SC 102). In questo breve passaggio i padri conciliari non hanno tenuto conto solo di una verità storica che cioè almeno fino alla seconda metà del II secolo i cristiani non conoscessero altra celebrazione che la santa convocazione settimanale nel giorno del Signore da cui poi è scaturita la solenne celebrazione annuale, ma hanno voluto soprattutto richiamare, in quell’ottica di nuovo slancio alla vita cristiana, l’importanza che da sempre questo giorno santo, fatto dal Signore, conserva per essa. «Quanti hanno ricevuto la grazia di credere nel Signore risorto non possono non cogliere il significato di questo giorno settimanale con l’emozione vibrante che faceva dire a san Girolamo: “ La domenica è il giorno della risurrezione, è il giorno dei cristiani, è il nostro giorno”. Essa è in effetti per i cristiani la “festa primordiale”, posta non solo a scandire il succedersi del tempo, ma a rivelarne il senso profondo» (DD 2). Le parole che San Giovanni Paolo II riporta nella sua lettera apostolica dedicata alla santificazione della domenica ci aiutano a recuperare la giusta visione non di un giorno di calendario ma di un modus vivendi che, non trovando più la sua giustificazione in un precetto ormai lontano dal sentire odierno, attende di essere nuovamente compreso e rivissuto. Celebrare la centralità della domenica significa innanzitutto riconoscere che la fede cristiana contrariamente ad ogni possibile riduzionismo etico, morale o culturale è la gioia di un incontro che trasforma, di un evento, quello della Pasqua, che coinvolge attirando e spinge in una costante uscita accendendo il desiderio. La domenica come spazio di apertura al Risorto nel sacramento della comunità cristiana diventa ribellione alla tentazione dell’assolutizzazione dell’uomo faber che può prendere anche noi credenti per ritrovare la gratuità di una relazione nella quale si rigenerano tutte le altre forme di rapporto con se e con gli altri. Partire dalla centralità della domenica cosi come fa da sempre la Liturgia che la vede non come fine ma come principio dell’intera settimana, cioè uscire dal weekend per ritrovare il giorno che trasforma il tempo aprendolo all’esercizio costante della speranza, se certamente non è un’operazione facile per noi, diventa quanto mai necessaria per liberarci da un certo senso di oppressione con cui non poche volte si vive il rapporto conflittuale con il tempo. Il giorno del Signore diventa per noi regola di vita cioè dono che chiede di costruire la nostra vita intorno ad un ordine nuovo che cambia il modo di vedere se stessi e la storia come accadde per i due discepoli di Emmaus. Ora tutto questo discorso potrebbe apparire distonico rispetto al senso della festa che le nostre comunità conservano ancora nelle celebrazioni delle feste popolari che sono in grado di galvanizzare le attenzioni di generazioni e stili di vita diversi, tuttavia a ben vedere si nota come spesso il convenire insieme nelle feste diventa quasi più un bene di consumo che un’esperienza formativa, un ritrovarsi su se stessi e sui propri sentimenti che una realtà altra in grado di fornire senso e significato, Forse qui sta la possibilità che viene offerta da questo nuovo sguardo che la comunità diocesana è chiamata a dare al suo vivere la festa nelle feste: le feste celebrate sono capaci di senso per la vita quotidiana? Riescono a tirar fuori l’uomo dalla tentazione sempre a portata di mano di rinchiudersi nel cerchio esasperante o esasperato del proprio io? È chiaro che queste domande pongono però alle comunità l’esigenza di porsi in uno stato di reale verifica circa il modo in cui viene vissuta la celebrazione domenicale come epifania del Mistero e quindi momento centrale della propria vita. In altre parole forse dovremmo esaminarci se le nostre assemblee domenicali sono mosse dal dovere, dall’abitudine o dalla necessità di lasciarsi toccare dal Risorto per essere da lui sempre guariti, tanto che si potrebbe dire: dimmi come celebri e ti dirò cosa e come credi.
Al cuore della Domenica: la celebrazione Eucaristica
Non vi è festa senza celebrazione e si può benissimo affermare che non vi è celebrazione senza festa giacché, come insegna la rivelazione biblica Dio è la festa dell’uomo. Ora in un tempo caratterizzato da una sempre crescente ansia di fare festa o meglio di inventare e vivere nuove feste, il celebrare cristiano appare incapace di suscitare l’entusiasmo dei nostri contemporanei perché forse noi per primi ci trasciniamo in un celebrare stanco che sembra aver affossato al freschezza della vita divina che lo abita, Eppure il cristiano non esiste senza la celebrazione, perché senza l’esperienza del rimanere con il suo Signore non può portare frutto. Si comprende allora come qui non ci sia in ballo un ricerca di forme nuove o più attraenti ma l’esistenza stessa della novità e della bellezza cristiane che vivono di un contatto costante e rigenerante con il Capo e le membra. Giustamente il Concilio afferma che « la vita liturgica della parrocchia e il suo legame con il vescovo devono essere coltivati nell’animo e nell’azione dei fedeli e del clero; e bisogna fare in modo che il senso della comunità parrocchiale fiorisca soprattutto nella celebrazione comunitaria della messa domenicale» (SC 42). In un tempo caratterizzato dalla crisi dell’appartenenza ritrovare il senso e il bisogno della comunità, diritto e dovere di ogni cristiano che sempre è chiamato ad edificare nella potenza dello Spirito il tempio del Signore, diventa il canale per saper cogliere quell’aspetto preponderante che sta alla base della visione della celebrazione eucaristica scaturita dalla riforma liturgica. Non più la celebrazione del presbitero a cui si associa per gentile concessione qualche laico volenteroso, ma una celebrazione strutturalmente comunitaria dove ognuno svolgendo solo il proprio ruolo con ordine e pietà (cfr SC 29) collabora a rendere presente il Signore e favorisce l’incontro dei suoi fratelli con il loro Signore. Ecco perché San Giovanni Paolo II nella Dies Domini afferma che «l’Eucaristia domenicale manifesta con un’ulteriore enfasi la propria dimensione ecclesiale, ponendosi come paradigmatica rispetto alle altre celebrazioni eucaristiche. Ogni comunità, radunando tutti i suoi membri per la “ frazione del pane”, si sperimenta quale luogo in cui il mistero della Chiesa concretamente si attua» (DD 34). Ritrovare la dimensione ministeriale che sostiene e illumina quella gerarchica dell’assemblea domenicale significa fare un vero proprio esercizio di Chiesa in un cammino mai compiuto e sempre felicemente in divenire nel quale lasciarsi abitare dallo Spirito senza il quale non esiste la Chiesa. Occorre quindi come saggiamente suggeriva don Luigi Girardi nel presentare all’Assemblea generale della CEI la nuova edizione italiana del Messale Romano nel 2018 recuperare due dimensioni essenziali del nostro celebrare. La prima è la coscienza che il celebrare stesso è anzitutto una grazia poiché in esso il Signore «ci fa degni di stare davanti a Lui e di servirlo» (Preghiera Eucaristica II). Diventa salutare per le nostre comunità ripensare le proprie celebrazioni festive nell’ottica della gratuità, cioè di quello spazio temporale altro in cui non si produce qualcosa ma si gusta la gioia di una presenza che precede ogni nostro sforzo e persino ogni nostra attesa chiedendo solo di essere riconosciuta e accolta. Se siamo coscienti che l’esperienza del monte non è e non può essere totalizzante neanche per la vita di un manco tuttavia lo spessore e il fascino della nostra vita cristiana in grado di tornare a far sentire il buon profumo di Cristo nasce solo dal poter dire anche noi «è bello per stare qui». Questa è bellezza con cui la Chiesa evangelizza e si evangelizza nella Liturgia secondo l’espressione di Papa Francesco nell’Evangeli gaudium (EG 24), bellezza non artefatta, costruita ne acquistata per efficienza ma generata dalla coscienza di un vuoto abitato da un tutto, dalla povertà dei meriti umani e dall’abbondanza della misericordia divina, In altre parole ci si chiede di tornare a gustare il Signore per essere raggianti e illuminanti, in grado di mostrare quella luminosità che nasce da un ascolto fatto carne e da una carne trasfigurata nella Pasqua. In questo modo la Liturgia, come ricorda il Papa nella Desiderio Desideravi, ci salva dal veleno dello gnosticismo e del neo-pelagianesimo. Infatti se « lo gnosticismo ci intossica con il veleno del soggettivismo, la celebrazione liturgica ci libera dalla prigione di una autoreferenzialità nutrita dalla propria ragione o dal proprio sentire: l’azione celebrativa non appartiene al singolo ma a Cristo-Chiesa, alla totalità dei fedeli uniti in Cristo. La Liturgia non dice “io” ma “noi” e ogni limitazione all’ampiezza di questo “noi” è sempre demoniaca. La Liturgia non ci lascia soli nel cercare una individuale presunta conoscenza del mistero di Dio, ma ci prende per mano, insieme, come assemblea, per condurci dentro il mistero che la Parola e i segni sacramentali ci rivelano. E lo fa, coerentemente con l’agire di Dio, seguendo la via dell’incarnazione, attraverso il linguaggio simbolico del corpo che si estende nelle cose, nello spazio e nel tempo» (Dd 19). Riscoprire la preziosità di questo noi se da una parte richiede certamente la fatica della carità, virtù donata e non innata anche nel migliore degli sforzi, dall’altra impegna la comunità ad uno stile nuovo di attenzione alla persona e al suo linguaggio, al suo sentire e al suo comprendere: un farsi accanto come il misterioso pellegrino di Emmaus per riportare sulla strada verso Gerusalemme, verso quel cenacolo grembo generativo nella forza dello Spirito di una umanità capace di armonizzare nella professione della vera fede i diversi linguaggi della famiglia umana (cfr Prefazio della solennità di Pentecoste). Questa apertura alla disponibilità dello Spirito propria del celebrare cristiano ci aiuta a non cadere nelle maglie del neo pelagensimo che « ci intossica con la presunzione di una salvezza guadagnata con le nostre forze, mentre la celebrazione liturgica ci purifica proclamando la gratuità del dono della salvezza accolta nella fede. Partecipare al sacrificio eucaristico non è una nostra conquista come se di questo potessimo vantarci davanti a Dio e ai fratelli. L’inizio di ogni celebrazione mi ricorda chi sono chiedendomi di confessare il mio peccato e invitandomi a supplicare la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e tutti i fratelli e le sorelle, di pregare per me il Signore: non siamo certo degni di entrare nella sua casa, abbiamo bisogno di una sua parola per essere salvati (cfr. Mt 8,8). …. Non si entra nel Cenacolo se non che per la forza di attrazione del suo desiderio di mangiare la Pasqua con noi: Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, antequam patiar (Lc 22,15)» (Dd 20).
Questo ardente desiderio di Dio non può lasciarci indifferenti ma deve trovare capaci di stupore in grado di ripuntare nuovamente sulla forza del Vangelo e sulla sua freschezza ancora accattivante per gli uomini e le donne di oggi. Ecco perche, come affermava don Luigi Girardi in quella bellissima relazione alla CEI, occorre dare fiducia alla liturgia, anche e proprio nella sua modalità rituale di farci vivere la fede: una modalità umile e rispettosa, forte solo della propria consegna al mistero di Dio. Questo sussulto di fiducia dice da una parte la nostra indisponibilità ad usare Dio o a volerne gestire le forze divine e dall’altra manifesta quanto ancora la Riforma Liturgica deve penetrare nei nostri cuori e nelle nostre menti attraverso la via paziente e perciò faticosa della formazione liturgica alla quale siamo condotti prima di tutto dalla Liturgia stessa. Formarsi nella Liturgia significa ritrovare la forza performativa di una parola che mi investe dall’alto, la capacità evocativa di un gesto che nella verità della mia umanità mi conduce ad Altro; significa ridestare quella capacità di volere dire l’invisibile nel visibile e di poter comunicare l’inesprimibile in un linguaggio fragile perché umano ma proprio per questo accessibile e comprensibile. In altre parole significa tornare a credere nel grande mistero dell’Incarnazione che mai dovrebbe smettere di sconvolgere le nostre rilassate e spesso rassicuranti visioni religiose per aprirci all’azione di Dio che in Cristo nella potenza dello Spirito continua a fare nuove tutte le cose. Saggiamente nel titolo di suo testo Mons. Crispino Valenziano definiva la Liturgia “Chiesa in corso d’opera”, una Chiesa che davanti all’amore sponsale del suo Signore non può restare ferma ma sempre si riconosce bisognosa di conversione e di un lavoro costante per adeguare se stessa ad un progetto unico che scende dall’alto.
Per il lavoro di gruppo:
- Il nostro celebrare domenicale è fonte di senso per le nostre comunità?
- Come possiamo risvegliare in ciascuno di noi una nuova risposta al desiderio di Dio che ci attende nell’assemblea domenicale?